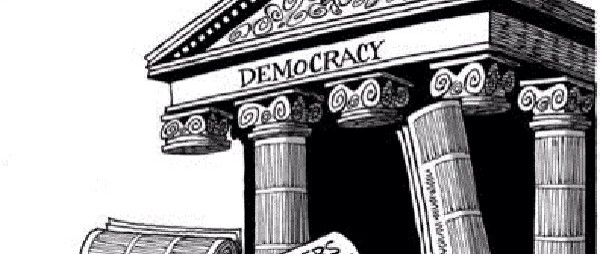di Gianfranco Sabatini (da Demo Sardegna-Democrazia Oggi)
Peter Mair, in “Governare il vuoto. La fine della democrazia dei partiti”, affronta il problema della crisi della democrazia popolare, tematica – a suo dire – “che affonda le sue radici nella problematica ben più ampia della frattura fra politica e democrazia popolare”, rilevando inoltre come, in conseguenza della perdita del ruolo tradizionale del sistema dei partiti, come il “controllo sul processo decisionale politico” sia uscito fuori dalla ”portata del normale cittadino”. Le conclusioni cui Mair arriva prefigurano un processo in itinere in cui, da un lato, i partiti non riescono più a svolgere il ruolo al quale erano stati chiamati, dopo il sorgere dello Stato di diritto, e dall’altro, la democrazia tende a sua volta ad adattarsi al cambiamento, con il risultato che “i partiti diventano sempre più deboli e la democrazia ancora più ridimensionata”.
Senza il sistema dei partiti – afferma Mair – “ci si trova in una situazione di assenza della democrazia”, oppure in presenza di un modello di governo, ancora “definito democratico”, in cui il riferimento al popolo è però ridimensionato, se non addirittura rimosso, poiché esso (il riferimento) è strettamente legato all’esistenza dei partiti. In conseguenza di ciò, è inevitabile il formarsi di una democrazia costituzionale “post-popolare”. A fronte del “vuoto” democratico che viene così a formarsi, emergono altri modelli di governo, sorretti da teorie di rinnovamento che propongono “nuove forme di politica istituzionale”. Queste teorie – sostiene Mair – condividono tutte l’interesse a “trovare o definire una nozione di democrazia che in primo luogo funzioni; che sia accettata in quanto legittima; e, da ultimo, che non ponga più al centro la nozione di controllo popolare o di responsabilità elettorale”.
La causa del crollo del sistema dei partiti è, a parere di Mair, riconducibile a un duplice versante: da un lato, i partiti hanno perso, o stanno perdendo, la capacità di coinvolgere i cittadini, la cui partecipazione elettorale, soprattutto a partire dall’inizio degli anni Novanta del secolo scorso, ha manifestato un trend orientato sempre più verso il basso e coniugato a un senso di appartenenza partitica in declino; dall’altro lato, i cittadini sono risultati sempre meno disposti a lasciarsi coinvolgere dai partiti. In presenza della convergenza di questa doppia tendenza, i partiti politici possono ancora presentare validi motivi programmatici per spingere all’azione i leader politici; ma, di fatto, i programmi politici sono utilizzati dagli stessi leader “come rampa di lancio per raggiungere altri uffici e posizioni”. In sostanza, i partiti starebbero fallendo, perché l’arena della democrazia partitica, in cui “i cittadini interagivano con i loro leader politici e condividevano un senso di appartenenza partitica, è venuta meno”.
La democrazia partitica, perciò, si è indebolita, e ciò si è tradotto nel disimpegno popolare dalla politica attiva e nell’affievolimento dell’interesse dei leader politici per le istituzioni dello Stato. Questo processo ha portato con sé alcune conseguenze tutte negative per la democrazia popolare: in primo luogo, il crescente vuoto che si è creato tra governanti e governati ha “facilitato l’emergere della sfida populista che attualmente caratterizza molte delle avanzate democrazie europee”, nonché una condivisa ostilità nei confronti della classe politica; in secondo luogo, l’indebolimento della democrazia partitica, seguito all’allentamento del rapporto tra governanti e governati, è valso ad affermare una “crescente accettazione e legittimazione dei processi decisionali non-politici o depoliticizzati”, quali sono, ad esempio, quelli di molte istituzioni dell’Unione Europea e delle agenzie internazionali, come l’Organizzazione per il Commercio Mondiale e il Fondo Monetario internazionale; in terzo luogo, l’allentasi del rapporto tra governanti e governati ha anche originato la propensione dei cittadini e dei politici a cercare la soluzione a controversie e problemi di natura politica, “attraverso soluzioni giudiziali”, in luogo di quelle politiche.
In conclusione, negli ultimi decenni, a parere di Mair, il mondo dei partiti politici, o dei loro leader, si è separato dai cittadini; per cui la democrazia partitica si è trasformata in una “democrazia del pubblico”, lasciando aperta la questione se siano gli elettori, con il loro crescente disimpegno, ad essere responsabili dell’”emergere di questa nuova forma di democrazia politica, o se, al contrario, si tratti di una nuova forma di democrazia politica che incoraggia questo disimpegno”. Quel che è certo – afferma Mair – è che i “due fenomeni si alimentano a vicenda. Nel momento in cui i cittadini lasciano l’arena della politica nazionale, inevitabilmente indeboliscono gli attori che continuano a muoversi quell’arena, ovvero i partiti politici. E ciò, a sua volta, è parte di, e promuove, la cosiddetta ‘democrazia del pubblico’”.
La crisi della democrazia popolare balza in modo particolarmente evidente, allorché si passa a considerarla a livello dell’Unione Europea, dove sinora è stata percepita, sbagliando, solo come “deficit di democrazia”. Alla luce dell’analisi di Mair, il problema del deficit di democrazia può essere meglio compreso se, considerato come esso è sorto, si analizza l’esperienza istituzionale vissuta dai popoli europei, sin dalla stipula dei Trattati istitutivi della Comunità Europea. Le istituzioni europee, infami, sono venute lentamente a configurarsi come un sistema politico, costruito dai leader politici nazionali, estraneo all’esperienza tradizionale dei partiti; in altri termini, come un sistema istituzionale al cui interno il processo politico poteva “evadere – afferma Mair – i limiti imposti dalla democrazia rappresentativa”.
Il sistema istituzionale, nato a livello europeo, infatti, non ha nulla dei caratteri minimi di una democrazia autenticamente popolare; non possiede, ad esempio, alcuno dei caratteri minimali propri della definizione di democrazia formulata da Joseph Alois Schunpeter: ovvero che la democrazia sia un sistema che richiede libera competizione per un libero voto, traducendo in procedura il classico accordo istituzionale, attraverso il quale i cittadini perseguono il raggiungimento di decisioni politiche tramite leader politici, che divengono loro rappresentanti a seguito di un confronto competitivo per la conquista del voto popolare.
Ora, questi caratteri minimali stanno cessando d’essere “considerati garanti assoluti della legittimità”, nel senso che ora le strutture del potere e del processo decisionale sembrano aver bisogno d’“essere protette dall’azione popolare e dai suoi ‘input’ eccessivi”. In altre parole, sembra essere divenuto necessario creare e proteggere le procedure decisionali “dagli ostacoli posti dagli obiettivi di redistribuzione” perseguiti normalmente dai partiti, salvaguardando gli obiettivi perseguibili dalle “inclinazioni predatorie dell’élite politica transitoria”.
La logica sulla quale si è consolidato il funzionamento delle istituzioni europee ha avuto un impatto negativo diretto sui partiti nazionali e sulle modalità che regolano la loro competizione: innanzitutto, perché il processo decisionale europeo ha ridimensionato il ruolo dei partiti, in quanto uno dei suoi principali effetti è stato quello di limitare lo “spazio politico” della competizione tra i partiti, attraverso l’armonizzazione delle politiche nazionali, che ha imposto un processo forzato di convergenza all’interno dell’area europea; in secondo luogo, perché lo spostamento del processo decisionale dal livello nazionale a quello europeo (come avviene, ad esempio per il governo della “moneta unica)” ha limitato le capacità dei governi nazionali, riducendone gli “arnesi politici” a disposizione; in terzo luogo, in quanto l’Europa ha avuto l’effetto di impedire “quelle che a lungo sono state pratiche politiche standard”, perché considerate interferenti con il funzionamento del libero mercato, quali, ad esempio, le politiche keynesiane di stabilizzazione dell’attività economica e di ridistribuzione del prodotto sociale.
Tutti i limiti indicati hanno finito col ridurre la competitività dei partiti nazionali, diminuendo le potenziali differenze dei governi che si succedono all’interno dei singoli Paesi membri. Ciò lentamente ha concorso, per un verso, a diminuire il significato delle politiche pubbliche e, per un altro, a rendere la competizione politica sempre più depoliticizzata. In questo modo, afferma Mair, l’Unione europea, anziché dare origine a uno Stato democratico, è divenuta uno “Stato regolatore”. In definitiva, essa è divenuta un sistema che “non può essere adeguatamente penetrato o al quale non si può avere accesso attraverso elezioni e partiti attraverso i tradizionali organi e canali rappresentativi”; ovvero, un sistema che è aperto a una gamma estesa di “agenzie”, “organizzazioni” e “attori”, ma nello stesso tempo inaccessibile ai detentori della sovranità politica, ovvero agli elettori.
A parere di Mair, è su questo punto che ci si devono porre gli interrogativi, del perché è stata creata un’Europa “apolitica” e del perché le sue istituzioni non sono motivate ad essere propriamente democratizzate, al fine di procurare un effetto positivo a cascata sulla competitività politica dei partiti nazionali. Per Mair, le ragioni possibili sono diverse: intanto, perché è sempre mancato il riferimento ad un “demos” unitario, a causa della mancata unificazione politica dei Paesi che hanno aderito al “progetto europeo”; in secondo luogo, perché i “decisori politici” sono sempre stati tendenzialmente motivati ad agire in funzione dei propri interessi “particulari”, piuttosto che in funzione del bene comune; infine, perché, più fondatamente, l’Europa è stata costruita per “fornire un’alternativa alla democrazia convenzionale”: da un lato, per via del consolidato antico convincimento che i meccanismi della democrazia popolare fossero diventati “sempre più incompatibili con le necessità dei policy-makers”; dall’altro, per l’antico convincimento che il problema delle elezioni imponesse “un limite troppo forte alla capacità dei governi di prendere decisioni per il bene comune”.
Qual è la conseguenza di tutto ciò? L’Unione Europea – conclude Mair – si è dotata di strutture che rappresentano “una soluzione ai problemi politici e alle questioni di credibilità che i decision-makers e ‘i loro clienti’ hanno dovuto affrontare, offrendo un mezzo per istituzionalizzare un sistema regolatore che non sempre può essere percorribile se dipendente dalle oscillazioni della politica elettorale”. In conseguenza di ciò, da parte di una folta schiera di “costruttori” di sistemi istituzionali, vi è stato uno sforzo orientato, non al ricupero delle democrazia popolare, ai livelli sia europeo che nazionale, ma volto unicamente a “ridefinire il concetto di legittimità”, in modo da configurare l’Unione Europea come un sistema di governo che non sia “convenzionalmente democratico”.
E’ vero che di continuo si sostiene che il sistema politico europeo è democratico, solo perché è “aperto e accessibile” alla rappresentanza degli interessi organizzati; ma è altrettanto vero che si tratta di un sistema politico che manca degli elementi costitutivi di una vera democrazia popolare. In particolare, nel governo dell’Unione, manca ogni dinamica governo-opposizione e soprattutto, quel che è fonte di maggior stravolgimento del senso della democrazia quale si era affermato dopo il secondo conflitto mondiale, manca di un’opposizione. Fatto, questo, che si sta ribaltando anche a livello nazionale, dove si pretende che le decisioni politiche siano allineate a quelle assunte a livello sopranazionale (chi non ha udito in questi ultimi anni affermare l’urgenza dell’adozione di un provvedimento impopolare solo perché l’”Europa lo vuole”?).
Non è casuale e privo di senso, perciò, il diffondersi, nell’opinione pubblica dei diversi Paesi membri dell’Unione, dell’euroscetticismo, destinato non certo ad esaurirsi, sin tanto che non si porrà rimedio alle cause reali (globalizzazione, sue istituzioni e sua ideologia) che sinora hanno ispirato solo un pensiero post-democratico.